Asseconda i sensi
Asseconda i sensi anche quando non ne hai voglia, quando pensi di avercela fatta, mentre la distanza per il traguardo è ancora lunga. Asseconda i sensi quando un brivido ti percorre la schiena, quando ti rendi conto di essere mortale, e che la tua vita è appesa al filo del destino. Asseconda i sensi quando ripensi alla caducità di tutte le cose e le tue membra ti sembrano stanche, quando la sorte tira i dadi, ma sai che la partita non è ancora finita. Asseconda i sensi quando tra i denti mastichi l’amaro senso della vita, quando il vento soffia così forte da esplorare luoghi reconditi. Affina i sensi quando una donna ti sfiora la mano o ti infila un papavero tra i capelli, quando non sai rispondere o ci sono cose che sfuggono ai moti della ragione, restando incastrati alle ancore gettate al largo del destino.
Asseconda i sensi quando l’ora diventa liquida e il tempo fa sparire i tuoi desideri dietro a un velo di tulle.
Asseconda i sensi quando ti ritrovi a parlare con le ombre dei passanti, quando ogni sguardo si perde nel cuore verde del vuoto dell’anima.
Asseconda i sensi quando l’aria si inebria dell’odore di un temporale e il suono di un nome dimenticato ti sfiora le labbra, salato come lo sono le alghe sulla riva.
Affina i sensi quando la notte non dorme e sogna per te, seminando presagi nei cassetti, tra vecchie carte ammucchiate ed ingiallite.
Quando senti che qualcosa ti chiama da sotto la pelle, una voce che non ha suono ma pretende ascolto, come fa il silenzio quando pesa.
Lascia che il passo segua la traiettoria dell’ignoto, ché solo chi cammina senza meta può riconoscere l’approdo.
E se la realtà dovesse spegnersi per un istante, non temere: forse è solo il mondo che trattiene il fiato, prima di raccontarti un segreto.

Nascere e morire
Sono nato nello squarcio di una ragnatela, tra una tazza di tè e un fiocco di neve. Chi mi conosce sa che la camicia la dismisi in quel tempo e mai più la indossai. Il tempo si era fermato sulle lancette di un orologio rotto, tra lo scroscio del piscio nell’acqua ferma del cesso, che suonava insaziabili battute sonore, tra ritmi incalzanti e soffi di vita ancestrali. Sono cresciuto in una baracca di legno e polvere, con in mano una bottiglia di rum e nell’altra le carte del destino, quelle che predicono la tua povertà e mettono termine alla tua iraconda perfidia. Il vento era gelido oltre la finestra, e gli alberi erano mossi da un maestrale che non si vedeva da diversi lustri. Oggi sembra primavera, ma dentro le ferite dell’anima sanguinano Giove e Marte, con spruzzi di sangue che sembrano tempeste dal vago sentore di un uragano. Sono morto in un blocco di cemento, calpestato dai fori che tolsero dai cannoni, imbevuto di spirito divino e del senno del poi. Ah quante volte gridai al mondo che era terminata la vita del destino e che la virtù dei forti non era più la calma, ma l’abitudine.

Non mi è dato sapere
Non mi è dato sapere come lascerò questa terra, su quale aeroplano fuggirò, innalzandomi su mondi sconfinati di terre verdi ed acque blu.
Non mi è dato sapere come verrà quell’aeroplano a prendermi, ne dove atterrerà. So solo che un giorno accadrà e non potró rifiutare il viaggio. Non mi è dato sapere l’orario della partenza, né tantomeno preparare la valigia. Per oltrepassare il bardo basterà la propria presenza. E quella dovrà essere cosciente, imponente, determinata e saggia, perché non sono ammessi cambi di biglietto, né tantomeno cambi di tragitto. Il mondo delle illusioni finisce così, con lampi colorati e coriandoli sciolti nell’acqua. Non mi è dato sapere se sarò accompagnato, né se sarò accolto con un aperitivo di benvenuto, come si fa qui, su questa terra misera di sentimenti e ricca di paure. La musica, però, voglio sceglierla io e voglio un sottofondo dei Sigur Ros, le tastiere piatte e gli archi che tessono trame oniriche, su una ritmica ossessiva e piatta. Voglio sognare, come ho fatto nelle notti più belle, baciato dal caldo delle stelle, dalla luce blu dell’universo, quando ho danzato sopra montagne di problemi e ho sorvolato le cime più alte che incoronano le mie valli. Non mi è dato sapere, ma io già so.

Poteri
Porterò con orgoglio la mia corona di spine: come un novello Gesù, camminerò verso il Golgota. Attraverserò la città vecchia, tra ali di folla, a volte muta a volte rumorosa.
Ci sarà chi gioirà, chi mi compatirà e chi mi sputerà addosso. Questi ultimi saranno in numero maggiore, perché umanamente è più semplice distaccarsi dal dolore, soprattutto quando non è il proprio. Ma camminerò sempre a testa alta con un mantello che coprirà le mie spalle nude e fragili, marchiate con i colori dell’arcobaleno, e con un copricapo, così come ho sempre fatto in tutta la mia vita. Le feste urlanti degli sciacalli e i banchetti ululanti dei lupi, non sono mai finiti, se non sono finiti dentro a pozzo, che ho prosciugato, a volte, con un pezzo di carta assorbente. Gli assoli dissonanti di individui stonati mi hanno perseguitato da sempre. E accendendo la radio ho ascoltato storie diverse dalla mia, ma, allo stesso modo, cariche di solitudine, saggezza e sofferenza. Ma io camminerò ancora a testa alta e porterò con orgoglio la mia corona di spine, che mi è stata donata da un mondo che corre e che non potrà capire mai ciò che io provo.

Sembra ieri
Sembra ieri che mi rincorrevi sui viali alberati che portavano al mare, mentre, invece, il tempo è trascorso inesorabile, ed io sono invecchiato e tu non sei null’altro che una donna anziana curva mentre cammini, dalla pelle bianca, a tratti emaciata, e dalle labbra spaccate dal tempo che nulla perdona. Sembra ieri che ridevamo seduti, stretti in un abbraccio, che in quel momento significava poco o nulla, ma che ha acquistato valore con il tempo. Perché, vedi, le cose, col tempo, acquistano importanza, almeno fino a quando non si rompono. E il nostro abbraccio, a un certo punto si è rotto e non abbiamo più saputo aggiustarlo. Avevamo il mondo nelle nostre mani e non lo sapevamo. Eravamo più forti delle nostre insicurezze, ed ora siamo pieni di fragilità. Eravamo giovani e certi come solo i giovani sanno essere, ed ora siamo solo un involucro che contiene sangue, piscio ed escrementi.
Siamo stati la vita, il rimorso, la distanza, la vicinanza, l’infinità. Ora siamo gli stessi di sempre, mischiati ad un elemento in più che si chiama fragilità. I calici si toccano ancora. Abbiamo novant’anni, il viale alberato che portava al mare, è diventato il viale del tramonto, alla fine del quale corriamo il rischio di vedere ancora il sole sorgere.

Mi piace
Mi piace correre in moto
Facendomi passare il vento tra le dita
Mi piace la velocità del pensiero e la calma profonda della parola
Mi piace il profumo delle zagare
E la pace di certi paesaggi
Mi piace il rombo del tuono
In risposta al lampo terrifico della luce
Mi piacciono le donne siciliane
La cadenza arabeggiante di certe ballate
Mi piace la musica rock la new age italiana, il free jazz punk inglese
Mi piace la frittata in mezzo al pane
E l’aria fresca dell’inverno
Mi piace camminare in montagna
L’aria ombrosa dei boschi mentre fuori arde
Mi piace il percorso irreale della fantasia
Che attraversa mondi immaginifici
Mi piace la natura rigogliosa
Il pascolo verde dei bovini
Mi piace stanare le talpe
Il rozzo gracidare dei rospi
Il fresco profumo dei tigli
E i grilli sospirosi che cantano d’amore
Mi piace!
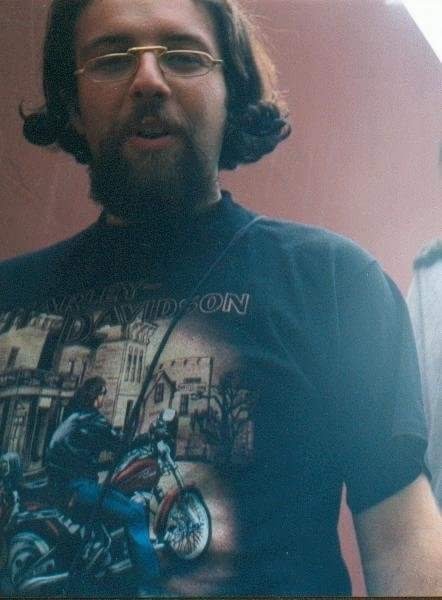
Vengo da 2000 anni di storia
Vengo da 2000 anni di storia
ma ancora non lo sai.
Ho una bicicletta verde opaco
e con lei attraverso campi sconfinanti
di paesaggi mistici dai colori sgargianti.
Il Sud mi aspetta.
Il Sud è qui, dentro di me,
avvolto dal Mediterraneo,
come avvolto può essere
un pezzo di pane giallo
o una bistecca di casertana
in un foglio di carta kraft, color avana .
Il Sud è racchiuso in una preghiera,
un lento salmodiare sul finire del giorno
sussurrato da una chiesa messa su uno scoglio
a picco sul mare, ingiallita dai ricordi,
falciata dalla salsedine.
Il Sud è il volo di un gabbiano
che dalla rupe Marina
arriva fino alla cima dell’ Appennino,
silenzioso come il vento,
navigatore esperto dei cieli del mattino.
Sento il frusciare dell’aria
il solletico degli insetti,
che mi attraversano il volto
quando corro sulla mia bicicletta.
Le donne mi salutano da lontano
piegate nei campi, sotto al sole cocente.
L’amore è fatto per le giovani
è un ricordo lontano,
che a volte ritorna,
come ritorna il treno
dai vagoni arrugginiti,
che una volta partì da Sapri
per andare non si sa dove.
Ho 2000 anni di storia
e me li sento addosso,
come un maglione intriso di sudore
come l’odore pungente delle cipolle
quando mia nonna prepara il soffritto.
Ho 2000 anni di storia
E me ne vanto!

Il canto del castagno e dell’amore rinato
Sotto l’ombra dei castagni, si incontrarono. Lei, donna, sorriso coinvolgente, occhi verdi e capelli scuri, piantava un albero. Lo faceva per ricordare un amore finito, un sogno volato in un alito di vento gelido di un giorno di fine aprile. Il clima, ancora inclemente di montagna, non lasciava scampo alle rondini che già avevano attraversato il mediterraneo per prepararsi, a nord, alla stagione degli amori e dei cuccioli. Nel punto esatto in cui un raggio di sole, attraversando le chiome fitte degli alberi, arrivava fino a terra, illuminando il tappeto delle foglie marcescenti, piantò la punta della pala. Smosse lo strato superficiale di terreno, sprigionando un profumo intenso di funghi e menta, e cominciò a scavare con forza.
Lui, uomo, scontroso, barbuto, portava addosso le ferite del tempo, proteggendosi con un’armatura, che, ad occhi inesperti pareva inesistente, ma che ad un esame più attento era radicata nei gangli dell’anima, arpionandosi al di sotto delle carni, dove l’anima si attaccava alle ossa, poco al di sotto degli organi vitali. Lui camminava distrattamente, con lo sguardo perso in quel territorio vagamente somigliante a quello, rigoglioso di vegetazione, visto in un film qualche sera prima.
Lei non fece in tempo a vederlo che l’anima le uscì dalla bocca, sotto forma di uno sbuffo di vapore, andando dritta verso il cuore di lui. Per forza di natura, loro già sapevano di essere gemelli, e di essere l’uno la parte mancante dell’altro. Non ci fu bisogno di parole, né di spiegazioni, ma tutto fu nel turbinio della natura, tra il profumo marcescente delle foglie a terra e il dolce richiamo della primavera, che si manifestava sotto forma di primule e fragole di bosco. Il pulieio rivestiva per intero il fondo del terreno su cui muovevano i loro primi passi. Lei lasciò lì la pala e il ricordo di quel vecchio amore. Camminarono su terreni scoscesi e salirono su, verso vette di piacere ed altipiani di cioccolato e panna. Camminarono ininterrottamente per giorni interi e notti infinite, concedendosi il tempo del riposo e del piacere. Buttarono via le scarpe, continuando a danzare una danza senza musica, fatta al ritmo dei battiti dei loro cuori.
Camminarono a lungo, lei e lui, mano nella mano, come se il mondo non esistesse al di là di quel bosco. Le stelle, nei rari momenti di quiete, sembravano alitare sopra i loro passi, e le ninfe dei boschi li osservavano con curiosità, nascoste tra i tronchi nodosi, sussurrando fra loro che un amore così non si vedeva da molte lune. Eros stesso, capriccioso e inarrestabile, aveva intrecciato i loro destini con fili d’oro e seta.
Ma un giorno, tra i riflessi verdi delle foglie e il canto distante degli uccelli, qualcosa si incrinò. Lei, che fino a quel momento aveva trovato rifugio e gioia nel suo abbraccio, cominciò a guardarsi intorno. Non più con lo stupore di chi cercava bellezza, ma con la curiosità inquieta di chi temeva di perdersi. Le promesse di mondi lontani, raccontate dal vento che sussurrava tra le chiome, iniziarono a chiamarla: miti forse falsi, forse ingannevoli, ma irresistibili.
Lui, sentendo il cambiamento nell’aria, cercò di tenerla vicino, di ancorarla a sé con parole che, però, scivolavano via, come acqua tra le dita. “Non vedi,” le diceva, “che questo è il nostro tempio? Che qui tutto canta di noi?” Ma lei ascoltava il vento più di lui, e i suoi occhi verdi, che un tempo erano stati specchio del loro amore, ora cercavano orizzonti che lui non poteva raggiungere.
Le ninfe, dispiaciute, cercarono di consolarlo, offrendogli fiori di lavanda e miele selvatico, ma nulla poteva colmare il vuoto che lei lasciava quando si allontanava, anche solo con il pensiero. Pan li osservava da lontano, scuotendo la testa, conoscendo bene la fragilità degli amori umani.
Le parole, che prima erano state un balsamo, si trasformarono in lame sottili. Ogni tentativo di spiegarsi si trasformava in un fraintendimento, ogni sguardo sembrava nascondere qualcosa di non detto. L’amore di un tempo,un fiume in piena, ora si arrotolava su se stesso, come un torrente che si perdeva in un gorgo.
Ma l’amore, quello vero, quello delle anime, non si spezza. Nonostante il vento contrario, nonostante le ombre e i dubbi, le loro radici erano intrecciate, giù, in profondità.
Una notte, mentre le stelle cadevano come lacrime dal cielo, Eros, infastidito dalle loro incomprensioni, scoccò una freccia d’argento, per ricordare loro ciò che già sapevano: che erano due metà dello stesso intero.
Si ritrovarono sotto lo stesso castagno dove tutto era cominciato. Lei, con le mani ancora sporche della terra di allora, e lui, con gli occhi pieni di tempeste e di promesse. Non servirono parole. Camminarono ancora insieme, questa volta senza paure, perché avevano imparato che il loro amore era un dono raro, qualcosa che neanche gli dèi avrebbero osato infrangere.
Il bosco, illuminato dalla prima luce dell’alba, si inchinò davanti a loro. Le ninfe cantarono un inno antico, e Pan sorrise tra le ombre, sapendo che, questa volta, l’amore aveva vinto.

Trafitto da sette spade
Sono trafitto da sette spade, che attraversando il torace, lacerano i tessuti, in particolare il pericardio e il cuore. Lo stomaco l’ho perso da tempo, con l’innocenza della fanciullezza e la sfrontatezza dei miei vent’anni. I peli sulla lingua, invece, non sono mai cresciuti, motivo per cui sono cresciuto in fretta, sfrontato e ribelle. A diciotto anni, mi innamorai di una puttana, che aveva le gambe piegate ad arco, ma mi voleva bene, come solo una puttana sa fare. Aveva due occhi neri come bottoni e braccia corte, a tal punto, che le mani non le ho mai vedute oltre le maniche. La bocca carnosa aveva, con gli spigoli rivolti all’insù, tanto da sembrare sempre sorridente oltre ogni misura. A diciotto anni ero ribelle, come solo a quell’età si può essere, e tamburellavo con le dita ogni oggetto di latta, come un percussionista, ma ero solo iperattivo nell’anima.
La mia anima, ora, è un campo arso dal fuoco sacro, un lembo di terra che la pioggia non bagna e che il sole non scalda più. Sono rimasto, o forse sono diventato, un viandante senza meta, un nomade in un deserto d’idee, con i piedi nudi che sanguinano sui ciottoli taglienti delle antiche verità infrante. Al mio passaggio, il vento solleva polveri di memoria che si infilano negli occhi come aghi, pungendo e risvegliando visioni che preferirei dimenticare.
Eppure, sotto la crosta di questo deserto, qualcosa pulsa. È la linfa di un albero invisibile, un Yggdrasil capovolto, le cui radici si nutrono delle lacrime versate dai giganti in esilio. Ogni spada che mi trafigge è un ramo di quell’albero, un ponte tra i mondi, e mentre sanguino, sento crescere dentro di me un’antica foresta simbolica. Gli animali selvatici si risvegliano nei miei pensieri: un lupo ulula il nome della luna, un corvo vola con un messaggio che non so leggere, una serpe si avvolge attorno al mio cuore trafitto e sussurra segreti mai dimenticati.
Nel cielo sopra di me, il tempo si dissolve. Il sole e la luna danzano insieme. Ogni passo che compio è un’offerta alla terra, un sacrificio silenzioso che il vento raccoglie e porta lontano, verso l’orizzonte. Ho perso l’aspetto da uomo; sono un ritmo, un battito che si fonde con il respiro del mondo.
La puttana dai bottoni neri mi appare in sogno, con le mani ancora nascoste, e mi dice: “Le mani che non hai mai visto sono le mani del destino. Le nascondo per non mostrarti quanto forte stringono le redini della tua vita.” La sua voce è il canto delle sirene, il richiamo degli abissi.
Mi sveglio in una radura che non ricordo di aver attraversato, circondato da alberi che sussurrano nomi antichi, mai pronunciati. L’aria è satura di resina e di preghiere dimenticate. Il tamburellare delle mie dita è diventato il battito di tamburi lontani, come quelli di un rito tribale che richiama spiriti antichi. Chiudo gli occhi e vedo immagini sovrapposte: templi crollati, altari insanguinati, danze selvagge sotto un cielo cremisi.
Non c’è più confine tra il sogno e la realtà, tra il sacro e il profano. E così, trafitto e sanguinante, continuo il mio cammino, seguendo il richiamo di un corno che riecheggia nella notte eterna, sperando che, al termine del viaggio, ci sia un’alba pronta ad accogliermi con il sorriso di una puttana dai bottoni neri e dalle mani nascoste.

I passi
I passi sul sentiero della vita a volte sono morbidi e leggeri talvolta sono duri come pietre, o turbolenti come il fianco spoglio del monte, travolto da una frana. Bouree era nell’aria, Ian Anderson era attaccato al flauto traverso e me lo immaginavo con il ginocchio sollevato e con la gamba piegata verso il basso, fin quasi a toccarsi il polpaccio. Ero in auto sulla Napoli Bari, nel tratto tra Grottaminarda e Vallata, e dall’autoradio si spandevano, a palla, le gesta erotiche di immagini immaginate tra le musiche dei Jetro Tull, che risuonavano per le valli circostanti, risalendo lungo i crinali delle colline, fino a raggiungerne le sommità, sulle quali dormivano distesi, piccoli paesini che assomigliavano più a un presepe mesto che ai fasti del passato. Una stradina passava sotto al ponte alto dell’autostrada, tagliando come una lama sottile il terreno tra le colonne, come un filo di cotone che passava nella cruna di un ago, e risaliva lungo il costone della collina. Il sole, già basso delle quattro, di un dicembre freddo e piovoso, si rifletteva sull’asfalto della stradina, dileguandosi in mille cerchi arancioni, che sfumavano in tonalità calde, allargandosi attorno ad una macchia gialla al centro, che risaliva lungo tutto il corso della strada. Non c’era verso di evitarla, se non distogliendone lo sguardo, puntando gli occhi sui terreni arati circostanti. Riconobbi il paese in cui terminava quella striscia di asfalto. Era Zungoli, antico borgo irpino, oggi paese dì frontiera tra la Campania e la Puglia, un tempo via di comunicazione tra la via Appia e la via Traiana. Oggi la via Herculeia, che ottemperava proprio al suddetto compito, coincide esattamente con quella striscia di asfalto, che, ancora, mette in comunicazione l’Appia, che passa ad ovest, attraversando il Formicoso, con la Traiana, che taglia il percorso ad est, tirando dritto da Benevento fino Monopoli, passando dietro Ariano, tagliando in due Savignano e sfiorando Grieci.
Terre aspre e dure, terre cresciute in altezza e nemmeno più di tanto. Come panettoni afflosciati per metà, come lampi nel terreno, saette che attraversano gallerie, le terre d’altura sono state per secoli terre di pascolo e di caccia, luogo di incontro di mute di cani o falchi solitari, che al fischio concordato, tornavano al braccio del padrone, che restava guardingo sul cavallo. Federico II, da qui ci passava spesso. Era uno dei suoi terreni di caccia preferiti. Il promontorio che scorre alla mia destra è il Formicoso, altopiano brullo e ventoso, dove la caccia diventava arte venatoria, corso per la sopravvivenza, luogo in cui si incrociavano addestratori di cani e falconieri esperti. Il mite Federico, questa terra la percorreva in lungo e in largo, beandosi delle delizie della natura, riposando, infine, le sue membra stanche presso il castello di Bisaccia. Oggi, come allora, l’odore dell’origano selvatico, riempie le narici dei profumi delle terre a sud, delle terre di altura e di pascolo; terre abitate da pecore e cristiani, da lupi, tassi e scoiattoli. Terre brulle e amare, terre che o si odiano o si amano.

Stati alterati di coscienza
Gli Stati alterati della coscienza erano il mare primordiale dal quale, pescatori di anime, tiravano su reti cariche di effluvi vitali ed escrementi. Nel mare alterato della coscienza avevamo catturato un’anima libera, che credeva di essere libera, con la quale ho colloquiato tutta la notte. Anche gli Dei erano passati da quelle parti, in barba alle raccomandazioni di Odino , camminando su un tappeto di suoni cupi e sostenuti, assistendo inermi alle discussioni tra le anime, fatte di parole forti e di profonda sincerità. Negli Stati alterati della coscienza venivano fuori verità scomode ed ancestrali paure, portate a spalla da lacerati sacerdoti isiaci.
Una voce maschile, grave ed alta nello stesso tempo, intonava motivi antichi, su una melodia prodotta da una tastiera su un tappeto di archi. Parlava la lingua dura dei vichinghi, che lasciava immaginare orme pesanti su una tundra ghiacciata, mentre il cielo, solcato da aurore boreali, si apriva in un caleidoscopio di colori primordiali. Le parole, scagliate come lance contro il silenzio, evocavano memorie di un mondo dimenticato, dove gli Dèi banchettavano e le anime trovavano il loro destino su campi di battaglia mistici. Eravamo poco più che macchie di luce.
Nelle profondità di quello stato, sentii il sussurro di Pan, il dio cornuto dei boschi, che danzava nudo tra ombre e fuochi, chiamando gli spiriti erranti con il suono del suo flauto. Era un richiamo irresistibile, che risvegliava desideri sopiti e paure primordiali, un inno all’unione nella danza sfrenata della natura, dove ogni maschera cadeva e ogni segreto era rivelato.
Freya, nel suo passaggio, aveva lasciato dietro di sé un profumo di ambra e muschio, mentre il fruscio dei suoi passi si faceva un tutt’uno con il canto degli sciamani, che invocavano la benedizione dei Nornir, le filatrici del destino. La rete tirata su dal mare alterato straripava di simboli: piume di corvo, amuleti di bronzo, frammenti di ossa, ognuno portatore di proprie storie.
E lì, tra le onde del subconscio, vedemmo un antico sacrificio consumarsi: un fuoco sacro acceso su un altare di pietra, dove il sangue versato era l’offerta, a ciò che era trascendente. Una sacerdotessa velata, forse un’ombra di Hekate, tracciava segni incomprensibili nell’aria, mentre un corvo osservava dall’alto, scrutando l’eternità con occhi gelidi.
Nel mare della mia coscienza alterata,, ogni visione diventava voce e portava un messaggio dimenticato, un eco delle ere pagane, quando gli uomini e gli dèi parlavano la stessa lingua e il mistero della vita era accettato,e non temuto. Forse, quella rete non è altro che un frammento del Wyrd, il tessuto del destino, che ci unisce tutti in un intreccio sacro e inscindibile.
(Giuseppe Tecce)

Da Grotta a Lioni
Coltivo questo pezzo di mondo con alacre assiduità, perché il particolare è sempre parte del tutto, e il tutto entra in ogni particolare.
A Grottaminarda ho trovato una casa, del colore delle arance di Sicilia, con un cane e quattro gatti, e in quella casa mi sono sentito a casa. Ha un grande giardino con alberi di mele e fichi e ulivi tutt’intorno. Un’amaca e un dondolo, messi in primo piano, su uno sfondo fatto di terra e poesia. In cielo c’è la luna, piena e tonda, luminosa come non mai, che illumina un cielo d’agosto terso e caldo. Il canto delle cicale non smette mai, nemmeno quando dalle Pleiadi pezzi di stelle si staccano per cadere sul pianeta, lasciando scie luminescenti per palpitanti emozioni. Il cuore batte forte, scaldando corpi che non vogliono cedere all’inedia della sera. L’indolenza delle anime si scontra presto con la verità del luogo. Generazioni sapienti di contadini maturi hanno coltivano per secoli quei terreni, ricavandone frutti e nutrimento. Zampe di vacche podoliche e pingui maiali hanno calpestato quelle terre, dove ora giace inerme, riversa in terra, un’unica foglia di fico, intrisa degli umori corporali e seminata come si fa con il grano. Non è il tempo dell’autunno, quando le foglie cadono come gocce di pianto dai crinali obliqui dei rami protetti. Non è ancora il tempo delle cadute, ma la foglia verde giace in terra, stemperando nei minerali del terreno gli ultimi suoi istanti di vita. Chiaramente è stata strappata via, chiaramente è stata messa lì, a ridosso dell’amaca, dove il cane amico, gioca scodinzolando a nuovi padroni. Il grillo abbassa la testa al mio passaggio, poi la rialza sistemandosi il cilindro. La mia capigliatura sciatta e rada nulla ha da spartire con la chioma lunga e profumata della padrona della casa. Ma nonostante il diverso, porto con orgoglio il trilby che nasconde le cicatrici del mio capo, e rassegnato mi preparo per il viaggio notturno nel cuore dell’Irpinia.
Le rane non hanno ancora smesso di gracidare, piccole luci sparse lungo il sentiero indicano la direzione che porta all’acqua. Il cane dalla coda dondolante, flemmatico mi scruta: ha una bianca peluria ed il passo di un pastore. Lei, invece, è ancora distesa sull’amaca, sazia di ogni sentimento, satolla fino all’orlo, satura di sudore e di ispirazione. Ha lunghi capelli neri, sciolti sulle spalle, mentre sorseggia una Peroni, guarda sorridendo la scena del cane che imbratta il nuovo padrone. Lo osserva divertita, poi dice di essere impaziente, che da donna ha terminato il tempo dell’attesa, che se non otterrà il tutto e subito, mollerà le redini e lascerà cadere la storia nell’oblio. Ma tu giovane donna non sai che la fretta porta sempre cattivi consigli e che la prima legge della vita è quella che ci impone di essere grati per quello che si ha. La gratitudine è il sentimento che ci riappacifica con la vita, la gratitudine apre le porte dell’invisibile, permettendoci di entrare in una dimensione che depone l’onirico in favore dell’essenza. Lei è giovane, lui non lo è più. Lei è governata dagli ormoni, lui da un senso di riappacificazione con il mondo. Lui le prende la testa tra le mani: “tesoro mio, abbi fede, tutto si sistemerà. Dai il tempo al tempo di fare il suo lavoro, sii orgogliosa delle mie vittorie, così come io lo sono delle tue. Gioisci per ogni nostro incontro, come il giubilo per il giorno di festa, come il giubileo delle anime che si incontrano per sempre, come l’incrocio dei corpi che si danno piacere. Tu ancora non lo sai, ma stiamo facendo la storia, presi dentro a un vortice di bellezza senza confini, dove tu sei la protagonista indiscussa. Dalle tue labbra pendono i battiti d’ali delle farfalle, dalla tua bocca possono sorgere fonti incontaminate di acque argentate. Ma se tu molli ora, prima ancora di averci provato, prima ancora di cominciare il percorso, se tu molli ora, avrai per sempre il rimorso ed un peso all’addome, che mal si addice ad una giovane donna, dal portamento delicato”. Così dicevano i due, dimentichi, quasi, della missione che dovevano portare a compimento quella notte, quale pegno del loro amore, quale sigillo chiuso sopra a un mondo impenetrabile agli altri, invisibile ai più. “Questa sera è una promessa, che scomparirà nel nulla se uno dei due smette di provarci. Sii costante, come lo sei in tutto ciò che fai, abbi la pazienza che hanno i forti, e mantieni sempre il sorriso che apre le porte e i cuori”. Ora è tempo di andare, la nostra eterna promessa, passa da un cammino che vale come luminosa promessa nel cammino buio che ci accingiamo a percorrere. A mezzanotte in punto, si parte”.
Viaggiare di notte assume un gusto particolare: una sorta di salto nel tempo, come quando da bambini non riuscivamo a cogliere i dettagli del paesaggio. Alle undici e quaranta lei si alza con indolenza dall’amaca che rimane dondolante. Lui ha già preparato uno zaino, con frutta, acqua e qualcosa da mangiare. Lei resta ancora vicina all’amaca, non vuole distaccarsene, non vuole cominciare il cammino. Si stropiccia gli occhi, per respingere un sonno che avanza, un sogno che arriva ed uno che se ne va. Alle undici e cinquanta sono abbracciati davanti al cancello. Lei palpita di sentimento puro, lui pende dalle sue labbra, dalla sua pelle giovane e sudata, come quella di una gazzella sfuggita all’attentato di un predatore. A mezzanotte in punto il cancello si apre, comincia il cammino di una vita, il sogno di una notte, l’afflato che li muoverà fino al mattino. Hanno deciso di arrivare fino a Lioni, di farlo di notte, come un tempo facevano i loro nonni, quando, per un voto o per diletto, ci si spostava da una collina all’altra, da una valle all’altra.
Lei riprende fiato, colore e profuma di rose. Lui mastica una liquirizia e odora di tabacco. Lui ha lo zaino sulle spalle, la mano in quella di lei. A mezzanotte e cinque minuti partono, passo dopo passo, carezza dopo carezza, sussurro dopo sussurro. Non ci vuole molto ad arrivare sulla provinciale che con poco più di due curve li porta a Carpignano. La Madonna, che da sempre abita quel luogo, li saluta alzando la mano, poi scostandosi i capelli gli augura buon viaggio. Da questo punto il percorso si fa in salita, si fa serio, i grilli cantano, la luna illumina il contado.
Salendo la salita la fatica arranca e il crinale del monte si fa più vicino. I passi passano in fretta, strusciando l’asfalto graffiato della via. Ad ogni masseria un cane abbaia, saluta con la coda e avvisa il socio più vecchio. Qualche cane si avventa sulla recinzione, ed i covoni di fieno hanno contorni nitidi al chiarore della luna. Un tasso ci taglia la strada, cammina goffo, taglia la via e si rituffa tra i campi. Non ha fatto caso alla nostra presenza, o forse non gli interessa. Sono le due quando tagliamo il bivio di Gesualdo, scegliendo di andare dritti sulla nazionale. A quest’ora non c’è gente, non c’è traffico, ma solo un via vai di curiosi scoiattoli dal mantello grigio. Poco più avanti di Pagliara, una famiglia di cinghiali, curiosa tra le nostre cose, grugnendo come maiali da recinto e amichevoli come un cane. Anatre da cortile starnazzano, allarmando la padrona, che dorme poco, accende la luce e si affaccia. “Chi c’è laggiù?” Grida, in direzione nostra, che con un poco di imbarazzo diciamo di essere viandanti, che per un voto alla Madonna, andiamo a piedi a Lioni. Due scoiattoli e tre marmotte ci seguono da un pezzo, sperando di ricevere il premio per tanta fedeltà. Spezzetto un po’ di pane e lo tiro in loro direzione. Gridano impazziti per il premio ricevuto, si fermano, ringraziano e sgranocchiano. Ci buttiamo giù per la discesa, che dopo le ultime case di Pagliara, porta dritta alla Mefite, poi a Santa Felice, ed infine a Rocca San Felice. La strada è secondaria, non ha più illuminazione. Io accendo una torcia, proseguiamo spediti. I cuori battono all’unisono quando un cane, di grossa taglia ci viene incontro con aria minacciosa. È pastore, pare del Caucaso, e il grugno sporco gli da un aspetto ancora più temibile. Ci annusa, ringhia, ci annusa ancora, sente l’odore del nostro cane. Siamo persone di fiducia, ci saluta con un inchino e si rifugia in una stalla, dove vacche succulente lo allatteranno fino al mattino.
La Mefite si fa sentire, con i suoi effluvi curativi e mortali. Le masserie nei pressi cominciano a prender vita. È l’ora in cui i contadini cominciano le attività nei campi, l’ora fresca che induce al lavoro; riposeranno quando il sole sarà alto allo zenit ed anche le cicale smetteranno di cantare. Dopo un breve tratto in salita siamo al cimitero di Rocca San Felice, dove ci compiaciamo di essere vivi e alla luce dei lumini ci scambiamo un bacio come segno propiziatorio e scaramantico. “Non è semplice essere vivi, oggi giorno, e per essere morti ci vuole meno coraggio”, dice lei, che afferra la bottiglia per il collo e ne butta giù un sorso, nella speranza che l’acqua diventi presto vino. Ma il miracolo non accade e le labbra si serrano forti al collo di lui, con la speranza di suggerne il nettare fatto di globuli rossi e globuli bianchi, dal colore amaranto, come il succo del melograno, come il vino novello, come la scorza del carmasciano lasciato ad invecchiare tra le vinacce. Ancora un poco e siamo al bivio di Sant’Angelo dei Lombardi, davanti all’ospedale illuminato, che fa bella mostra di se, silenzioso, nella notte nitida. Solo un gatto passa di lì, ci snobba e tira dritto. Ma si sa che i gatti sono diffidenti, e degli umani non hanno confidenza, con la speranza, nemmeno recondita, di dominarli, in un mondo fatto al contrario, di gatte solitarie che portano da mangiare ad umani da compagnia. Sono secoli che lo desiderano, ed il loro volere prima o poi si avvererà, per l’intanto filano via dritti con aria schifata, con passo regale e felpato. Ancora qualche curva e la sagoma sciapita di un templare ci viene contro, con la spada sguainata e sollevata, l’elmo calato sulla testa, la visiera ben abbassata sopra agli occhi, ed un mulo al posto del cavallo. Mi viene da ridere, ma lo salutò con un gesto della mano, sento un moto di piacere che sale dall’ armatura. Accanto a noi tira dritto, non ha tempo da sprecare, deve andare in guerra, perché la santa l’ha perduta ormai da un pezzo. Viene dal Goleto, dove ha riposato, per secoli fecondi di riposo e umanità. Ancora poche curve e siamo giunti alla metà. Un murales con un bambino in procinto di lagnarsi, ci accoglie con gran sorpresa e colorazioni. Alle sei in punto siamo nella piazza, dominata dalla chiesa della Santissima Assunta Maria, che dopo averci lasciati a Carpignano, ci accoglie come una madre che aspetta l’arrivo del figliolo.
Noi ci guardiamo, l’alba sta sorgendo appena e sopra agli Appennini, tra gli Alburni e i Picentini, si levano nuvole di fumo, come fuochi d’artificio, suffumigi di benessere animici. Noi ci abbracciamo, ci baciamo e cadiamo stremati su una panchina. Dormiamo.

Franco Battiato ed i Dervishi rotanti ad Istanbul

Correva il mese di Aprile del 2014 e ancora una volta Battiato entrò con prepotenza nella mia vita. Ero ad Istanbul per un progetto europeo sulle disabilità. Dopo 4 giorni di lavoro ad Izmit sul mar di Marmara, ci trasferimmo ad Istanbul per una due giorni di immersione nella vita cittadina. Dopo una lunga giornata, trascorsa tra Aghia Sophia, la Moschea Blu ed il Suq, mangiammo baklava come se non esistesse un domani, ed arrivò la sera. I miei colleghi decisero di continuare la serata, mangiando in un ristorante sul Bosforo. Ma io avevo ben altri programmi per la mente, più che una semplice cena in compagnia.
Dopo intere giornate passate ad ascoltare e a cantare “Voglio vederti Danzare” di Franco Battiato , il verso relativo ai Dervishi Rotanti mi rimbombava nel cervello. Potevo non approfittare della mia presenza ad Istanbul per andare a salutarli, a parlarci, ad abbriacciarli? Così, sfanculati i miei colleghi, mi recai spedito dal portiere dell’hotel e gli spiegai, seppur con un inglese claudicante, della mia passione. Ci pensò per un attimo, poi, con voce ferma, mi comunicò: sei fortunato, oggi è giovedì ed è il giorno in cui si riunisce una confraternita Sufi dove ci sono i Dervishi. Chiamò immediatamente la confraternita al telefono, si accertò che gli stranieri fossero ammessi, e mi prenotò un taxy, che arrivò di lì a 10 minuti, dandogli indicazioni precise sul dove portarmi. Il tassista parlava solo in turco ed era complicatissimo approcciarsi a lui. Presto lasciò le strade principali cominciando a spingersi nei vicoletti della città antica, pavimentati a basoli e illuminati da lampioni a luce gialla. Era la città più antica, quella romana. Arrivò fin dove poteva, poi si fermò. La macchina non poteva procedere oltre, i vicoli erano eccessivamente stretti. Mi fece scendere, pagai e mi indicò con la mano di andare, dapprima, dritto e poi di svoltare a destra. Erano le 20.30 di un giovedì di aprile. Era già notte fonda, nei vicoli non c’era anima viva e tutte le case erano chiuse. Mi incamminai, così da solo, nella direzione che mi aveva indicato, sperando di aver capito bene. Fortunatamente dopo 5 minuti di cammino tirai un sospiro di sollievo, quando in fondo ad una strada, vidi un’insegna accesa con una parola che assomigliava vagamente a quella di confraternita. Bussai alla porta e mi aprí una donna, gentilissima. Mi prese con cura il giubbotto e lo appese all’appendiabiti, mi fece togliere le scarpe e le ripose in una enorme scarpiera a muro piena fino all’inverosimile di altre scarpe. Poi, scalzo mi fece entrare in una grande sala con una grande rotonda di legno al centro e due spazi laterali, uno a destra ed uno a sinistra, allestiti con delle sedie. Seduti sulle sedie di sinistra vi erano solo uomini, e in quelle opposte, a destra, vi erano solo donne. La signora che mi aveva accompagnato mi disse in inglese che era proibito fare fotografie e si congedò. In 10 minuti fecero ingresso sulla rotonda circa 10 uomini, vestiti con mantelli scuri, che ben presto tolsero mostrando gli abiti tipici dei Dervishi, bianchi, con la parte bassa formata da una gonna scampanata che avrebbe dato vita a quella tipica figura dei Dervishi rotanti, quando avrebbero iniziato a girare. Un uomo più anziano li toccò sulla fronte, uno per uno, dando inizio alla parte mistica. Recitando delle preghiere i 10 uomini si diedero a volteggiare al centro della rotonda, prendendo presto la tipica posizione dei dervishi rotanti in preghiera. Si perché in sostanza, quello è il loro modo di pregare. Sono asceti della religione musulmana, accaniti sostenitori della pace e per questo, spesso, non ben visti dai musulmani radicali. Nel mentre che si svolgeva lo spettacolo, ci portano delle vivande: prima dei contenitori con una sorta di pasta, che sembrava cotta al forno, e poi una bevanda a base di kefir, veramente buona. Finiti tutti i volteggiamenti, dopo circa 45 minuti, prese la parola un uomo anziano, ben vestito, che, seduto al centro della rotonda, che cominciò una predica. Non so cosa dicesse in turco, ma una cosa la so per certa e cioè che tutti i presenti all’unisono iniziarono a piangere, in un pianto a dirotto, che non trovava consolazione. Finita la predica, tutti i presenti si misero in fila davanti a quest’uomo ed iniziò un baciamano intenso, anzi qualcuno gli si buttò ai piedi, baciandoglieli. Per non mancare di rispetto a questa persona, mi misi anche io in coda e gli baciai la mano. Finito tutto quello che c’era da fare, verso mezzanotte uscimmo all’esterno del centro culturale. Solo, spaesato, senza sapere la lingua e senza sapere dove mi trovavo, feci una decina di passi verso la fine del vicolo, quando dalla strada di dietro sbucò una macchina, grande, una di quelle a 7 posti, e dentro si sbracciavano 4 persone, che poi riconobbi essere presenti nella sala. Di fatto si offrirono di accompagnarmi in hotel e con un’ospitalitá come poche mi offrirono da bere, e poi gomme da masticare e quant’altro fino a quando non mi lasciarono davanti all’ingresso dell’hotel.
Anche in quella giornata fui grato a Franco Battiato che aveva influenzato l’andamento della mia giornata e della mia esistenza.
Ps: le foto che qui posto sono un dono, perché sono riuscito a scattarle di nascosto in un centro culturale Sufi di Istanbul, dove scattare foto era severamente vietato.




Germano, le podoliche e il Lago Laceno
Germano l’ho incontrato una mattina di Luglio. Era un sabato o forse una domenica. Poco conta, perché qui il tempo sembra essersi fermato. La strada che porta a Lago Laceno è una striscia d’asfalto scura che si srotola tra i crinali di un monte sempre verde, sempre ricco di vegetazione. Ha la sua base a Bagnoli Irpino ed è da lì che la via si biforca portando, da un lato, ad Acerno, e dall’altro, inerpicandosi su per il monte, dove l’aria trova refrigerio, e la cincia canta in sincrono con il picchio. Germano è un tipo diffidente , poco avvezzo ai rapporti umani, guida le sue mucche, di razza podolica e tanto gli basta. Io mi sono seduto da un lato, sul pianoro che riempie la valle stretta tra le cime più famose del Laceno. Dietro di me svetta alto il Cervialto, che con i suoi 1800 mt è una delle cime più alte dell’Appennino centro meridionale. Ci troviamo sul massiccio dei Monti Picentini, roccaforte degli Irpini, quando facevano parte della confederazione dei Sanniti. Un popolo forte, ostile, ribelle, forse il più forte e ribelle di tutte le popolazioni del Sannio. Guerrieri indomiti, usavano contro le legioni dell’esercito romano le tecniche della guerriglia, quella che si usa ancora oggi negli attacchi nelle foreste. Salivano, scendevano su e giù per i monti, praticando attacchi fulminei che lasciavano senza scampo. La conoscenza del territorio era l’elemento chiave di quella tecnica. Sapevano bene come e dove muoversi, dove attaccare e dove nascondersi. Un vantaggio non da poco, in un’epoca in cui non esistevano mappe, ne cartacee, ne tantomeno digitali. Ma l’esercito Romano non tollerò a lungo un tale affronto e poco tempo dopo quelle popolazioni, fiere ed indomite, furono sconfitte e relegate ai margini della storia, praticandogli la damnatio memoriae. Tale evento, se da un lato fu deleterio per le popolazioni dell’epoca, dall’altro permise che le stesse su evolvessero secondo una propria cultura e propri codici morali e legislativi di riferimento. Tale isolamento, accentuato ancor più dall’abbandono della via Appia Antica, che attraversava una parte dell’Irpinia, tagliando in due l’altopiano del Formicoso, per dar spazio alla via Appia Nuova, ossia la via Traiana, inaugurata dall’imperatore Traiano, e con il suo inizio nella città di Benevento, aveva generato una progenie altrettanto forte ed autonoma, capace di vivere in zone impervie e con un clima inclemente, che avrebbe facilmente demoralizzato le altre popolazioni dell’impero. A niente servì l’innesto di una popolazione prelevata nell’area Picentina, da cui deriva il nome di monti Picentini. I Picentini si amalgamarono bene con gli irpini, creando una popolazione ancora più fiera ed autonoma. Quelle caratteristiche ancestrali si possono notare bene ancora oggi nelle popolazioni locali.
Germano è un inconsapevole portare di quei geni che lo rendono altezzoso ed autonomo, mandriano di poche parole, ma esperto conoscitore del territorio e del proprio mestiere.
La prima parola ce la siamo detta quando una delle sue mucche si è avvicinata troppo a me, finendo per calpestarmi un piede. Fortunatamente il terreno morbido sotto le scarpe ha scaricato bene il peso dell’animale. Ne sono uscito con qualche contusione e qualche dolore al piede. Germano si è rivolto a me chiedendo se mi fossi fatto male, ma senza creare allarmismi o inutili ansie. “Gli animali sono pesanti e questo è il loro territorio. Probabilmente non ti ha nemmeno visto”, sentenziò con un linguaggio scarno ed essenziale.
“Si sa che la vista delle mucche è scadente” , rispondo io, più per attaccare bottone che per una reale necessità di trasmettere quell’informazione. Probabilmente, lui, mandriano di professione, ne sapeva molto più di me, e non tanto perché lo avesse studiato sui libri, ma per esperienza diretta, sul campo.
Caccio prontamente dallo zaino una bottiglia di Taurasi, regalatami da un’amica e portata sul campo proprio con l’intento di farlo trasbordare dallo stato solido della bottiglia a quello liquido delle vene.
Germano, dapprima diffidente, guarda la scena con un piglio accigliato, poi, senza proferire parola, si allontana, arrivando alla sua tracolla, appoggiata su di un palo, tirandone fuori una pezza di formaggio ed un coltellino. Il formaggio era avvolto in uno straccio di cotone, si siede accanto a me, ne apre i lembi e ne taglia due fette. Tanto era brutto a vedersi dall’esterno, quanto era candido, compatto e bello nella parte interna. Il coltello affonda come se fosse burro, il profumo di fieno di pascoli d’alta quota si libera nell’aria e me lo porge con una inaspettata gentilezza. Poi mi passa anche il coltellino. “Provvedi tu stesso a togliere la crosta che può contenere delle muffe”.
“Lo produci tu?” Chiedo con l’aria impacciata di chi di formaggi non ne sa poi molto.
“Lo produco io” ribatte rapido lui, precisando che dopo averlo prodotto lo fa maturare per almeno quattro mesi in una grotta, nei pressi della propria abitazione. “Una grotta naturale”, precisa, “e non, di certo, una di quelle artificiali che si usano oggi per far maturare in fretta i formaggi. Il formaggio ha bisogno del suo tempo, e se acceleri il processo, quello che ottieni non sarà più un formaggio di qualità, ma uno dei tanti formaggi industriali, fatti per far arricchire qualche spregiudicato industriale, impoverendo i mandriani, che, tuttalpiù, gli vendono il latte per quattro spiccioli”.
“La solita storia che si ripete, dei furbetti che cercano di approfittarsi dell’economia di massa, e dei poveri cristi che lavorano sodo per portare a casa un tozzo di pane”, concludo io.
“Esattame, proprio così” risponde lui, mentre allunga il braccio per prendere il bicchiere che avevo riempito di nero aglianico.
Il vino fa sciogliere il sangue e le lingue, così Germano mi racconta di essere di Materdomini. Ci tiene a precisare che non vive nella frazione, ma in una casa di campagna. Di mestiere fa il vaccaro. Possiede oltre 100 vacche, che accudisce con il fratello, Pino, che nel momento in cui parliamo, è dall’altra parte del pianoro, con una parte della mandria e tre dei sette cani che li seguono.
“Non sapevo che i vaccari si spostassero con i cani”, gli dico io, lanciandogli l’assist per scioglierlo definitivamente.
“Pensavi che solo i pecorari avessero i cani? Ti sbagliavi di grosso. I cani svolgono un lavoro importante e delicatissimo, perché tengono insieme la mandria e non lasciano che i singoli animali si muovano autonomamente.”
“A Materdomini non ci sono mai stato”, gli ribatto io, cambiando completamente discorso.
Germano sgrana gli occhi, come se avessi commesso un sacrilegio. “ Non è possibile che tu non conosca il santuario di San Gerardo Maiella. Materdomini è famosa per quello. Per il resto altro non è se non un piccolo agglomerato di case , appartenenti al comune di Caposele.”
“Mi dispiace deluderti, ma davvero non ci sono mai stato, ma considerata la bontà dei vostri formaggi, di certo verrò a farci un giro”.
“Aspetta, ribatté prontamente Germano, non tutti i formaggi di Materdomini sono buoni, anzi, direi che sono piuttosto mediocri. Invece il mio formaggio è eccellente, ma , come vedi, dietro questo sapore c’è un lavoro enorme”.
“Ma la mandria la tenete sempre su questo pianoro?” Chiedo un po’ titubante.
Germano accenna un sorriso: “ certo che no. Hai mai sentito parlare di transumanza?”
“Ovvio che ne ho sentito parlare” rispondo prontamente io, che la materia la conoscevo per davvero.
“Bene, e ora la vedi in atto. Ogni anno, per la stagione estiva, io e Pino trasciniamo la mandria fin quassù.”
“A piedi?” Chiedo con un pizzico di meraviglia.
“Il grosso si, viene a piedi. Poi, ci sono gli animali più giovani, ma anche quelli più vecchi che vengono trasportati con dei camion. Una volta qui, posso pascolare libere per tutto il periodo estivo. Abbiamo costruito una recinzione leggera, solo per la notte”.
Germano butta un’occhiata furtiva all’orologio. Capisco che è tempo che vada.
“Devo mungere le vacche, e ne avremo per un po’,” disse con l’aria di chi era costretto ad abbandonare il convivio.
Mi lascia andare e gli do una pacca sulla spalla. Germano è un gran lavoratore. Ha un’età indefinita, tra i trenta e i quarant’anni. Indossa un jeans ed una t shirt. Ma soprattutto è un uomo generoso. Prima di andare via, avvolge di nuovo la pezza di formaggio nel fazzoletto di cotone, poi me lo porge: “questo è un regalo per te”.
Io lo accetto commosso. Non se ne trovano più in giro di uomini così. (Inedito da “I racconti dall’Irpinia, Giuseppe Tecce”)

A Rocca San Felice
Gerardo era arrivato in fretta, dopo la mia chiamata. Era arrivato con una Golf nera, tutta smantellata, con il paraurti anteriore appeso da un lato, il faro mancante, ed un lunghissimo struscio sulla fiancata, dallo stesso lato. Era arrivato da Rocca San Felice, alle diciannove in punto. Io ero seduto all’ombra di un fico, proprio di fronte all’abitazione. Davanti a me un tavolino tondo di ferro, lavorato, credo, artigianalmente e quattro sedie in ferro battuto. Io non sapevo, di preciso, dove mi trovassi, né tantomeno sapevo la distanza tra quell’abitazione ed il centro abitato più vicino. Queste cose le avrei scoperte in seguito.
Ciò che vedevo era ciò che esisteva, dal mio punto di vista, e ciò che vedevo era una casetta a due piani, di forma rettangolare, colorata di un giallo paglia, e sulla sinistra, attaccata ad essa, un’ulteriore casetta, anch’essa rettangolare, più piccola e colorata di bianco. Tra il giardino in cui sedevo, e la casa gialla c’era una strada; stretta, con un’unica carreggiata, ma messa bene, appena asfaltata, che contrastava con il disordine che c’era tutto intorno. E tutto intorno a me, c’era il disordine: un trattore arrugginito, da un lato, un altro trattore dal quale era stato asportato un pezzo anteriore, appezzamenti di terra coltivati a foraggio, dove il grosso del foraggio era stato tagliato e sistemato in grosse rotoballe, con scarti di paglia sparsi sul terreno, che il vento forte della sera spargeva anche sulla strada. Ce n’era di vento sabato sera, nonostante fossimo solo al primo week end di agosto. Tutt’intorno, gli alberi non davano l’idea di essere molto in forma: rami secchi, foglie ingiallite e spazzate via dal vento.
Il vento, quello sì che sapeva fare bene il suo mestiere, sabato sera. Soffiava forte da sud-ovest il vento di libeccio, spazzando via l’afa del giorno, zittendo le cicale, mettendo fine alla quiete calda della controra, riponendo al sicuro e a riposo la bestia del grano, che aveva poco da fare, ormai, ora che il grano era stato mietuto. Qualcuno, però, già dalle parti del Formicoso, da dove provenivo, mi aveva avvisato che, nonostante la mietitura anticipata dal gran caldo, la bestia del grano continuava a scorrazzare indisturbata per i campi tagliati della zona ed in tanti avrebbero giurato di averla vista nell’arco dell’ultima settimana.

Mi ero fermato al margine della strada, poco prima del bivio per Guardia Lombardi, e mi ero messo a fare conti con un simpatico signore che armeggiava su un trattore. Non ci volle molto che la combriccola si allargasse e che si finisse a parlare proprio di mietitura e della bestia del grano. Tutti i presenti erano certi di averla vista almeno una volta nella vita, confermando l’antico proverbio: “una volta nella vita non si nega a nessuno”. Più complicata diventava la faccenda quando il discorso si spostava verso gli avvistamenti fatti nel periodo successivo alla mietitura. A quel punto il gruppetto si spaccava in due parti: da un lato c’erano Antonio, Pasquale e Carminuccio, tutti e tre di una zona più vicina a Guardia Lombardi, che sostenevano che dopo la mietitura era impossibile osservare la bestia, perché era venuto meno il suo habitat naturale. Dall’altro lato c’erano Luigi, Generoso e Gerardo, che erano della zona di Oscata, che sostenevano di aver avvistato la bestia anche dopo la mietitura. Uno di loro, addirittura, si era spinto a farmene una descrizione: “era come una faina ma con una lunga coda bianca”, sollevando le ilarità dell’altra parte che, tra sghignazzi e sgomitate, sosteneva che fosse, per l’appunto, una faina.

Gerardo di tutto ciò, però, non ne sapeva nulla e poco gli interessava. Parcheggiata la Golf davanti alla casa bianca, era sceso, venendo dritto verso di me, con la mano allungata in avanti, in segno di saluto. Era alto poco più di un metro e sessanta, rotondo quel tanto che serviva da dargli un aspetto da contadino rubicondo. La mano callosa, che indicava una vita fatta di fatica manuale nei campi, contrastava con la pelle liscia della mia; una mano da ufficio, da uomo cittadino, poco avvezzo ad avere a che fare con i lavori manuali. Ci stringiamo la mano, è gioviale e cordiale. Mi sciolgo, mi metto a mio agio e divento cordiale come lui. Si siede di fronte a me, e comincia subito a parlare: “da dove vieni?”
Gerardo la tua domanda si presta ad una duplice interpretazione: con la domanda “da dove vieni” vuoi chiedere la mia città di provenienza, oppure il luogo da cui provengo e dove ero prima di venire qui?
Gerardo ci pensa un po’, poi, con tutta tranquillità mi dice: “no, no, voglio sapere proprio di dove sei?” Poi, con un mezzo sorrisetto, aggiunge: “che mi frega da dove stai venendo oggi”.
“Ecco”, rispondo io, con altrettanto sorriso, “ora sì che la domanda è più chiara: vengo da Benevento”.
Gerardo si illumina: “Benevento! La frequentavo spesso, venti anni fa, mi dice. Ma è ancora la bella cittadina di allora?”
Cerco di tagliare corto: “la città resta sempre la bella città di una volta, solo che è amministrata male”.
Mi fa qualche domanda sull’amministrazione, ma cerco di glissare: “Gerà, sono venuto per riposarmi, non di certo per parlare di politica”.
Gerardo sorride, comprende il mio disappunto e cambia subito argomento.

Mi racconta, come se ci conoscessimo da sempre, che per tre anni era rimasto bloccato a letto, con una brutta ernia del disco, che lo aveva quasi paralizzato. “Pesavo 67 kg, prima di quell’episodio, poi, che vuoi farci, i farmaci, il cortisone, l’immobilità mi hanno ridotto così. Ora di kg ne peso 94”.
“Non va bene” gli faccio eco, “sei ancora giovane e dovresti rimetterti in forma”.
“Giovane” sorride lui. “Quanti anni mi dai?”
Lo guardo, lo scruto, poi sparo la mia sentenza: “A mio avviso non hai più di 56 anni”.
Gerardo sorride divertito: “di anni ne ho 62”.
“Complimenti”, rispondo. “Al di là della faccenda del peso, non te li porti male”.
“Due cose mi hanno salvato dal calvario: le bestie”, ed indirizza lo sguardo verso i cani, i gatti, che scorrazzavano liberamente sotto ai nostri piedi e poi alle mucche che pascolavano poco più in là.
“E poi”, gli faccio io di rimando.
“E poi”, continua lui illuminandosi in un sorriso ancora più luminoso, “mia moglie e mio figlio”. Poi si ferma, ci pensa su un po’, poi continua: “è la mia quarta moglie, sia ben inteso. Ho già due figlie grandi, di 40 e 35 anni che vivono lontano da qui. Quest’ultimo mio figlio, il maschio, ha ventidue mesi”.
“Me lo fai conoscere?” gli chiedo con spontaneità.
“Ora sono in Ucraina. Lei è di Odessa, ed è andata lì per stare un po’ con la famiglia. Ma credo che sia quasi ora di tornare”.
Gerardo si commuove a parlare dell’ultima moglie e soprattutto del tanto atteso figlio maschio. Se ne accorge e cerca di togliersi dall’impaccio: “ora devo governare e chiudere gli animali”.
Appena si alza dalla sedia, accorrono una decina di cani ed un gatto dalla coda arricciata.
Gli chiedo se fossero tutti suoi quei cani. Lui mi risponde che solo i due pastori scozzesi, Alfonso e Rita, erano propriamente i suoi cani, tutti gli altri erano dei cuccioli randagi della zona, che un po’ per volta si erano aggregati e che, ora, facevano parte della sua famiglia allargata. Li chiamava tutti per nome, ed avevano tutti un nome di persona: Alfonso, Rita, Franco, Gennaro, Anna, e così via di seguito, per quanti cani c’erano.
Capii subito che, a dispetto dell’aspetto fisico, il suo cuore era grande e che, per lui, non c’era poi tanta differenza tra animali ed esseri umani: tutti, a suo avviso, erano dotati di un’anima e, in quanto tali, erano degni della sua compagnia e della sua custodia.

Mi accompagnò, frettolosamente, nella camera che mi aveva riservato per la notte, al secondo piano della casa gialla. Passammo attraverso una grande sala da pranzo, poi salimmo delle scale esterne, e da lì apri la porta che dava nella camera da letto, che affacciava sul retro della casa. Lui scese, indaffarato, per sistemare le mucche e le tante pecore che pascolavano libere tutto intorno. Le sistemò in un grande recinto, ed io lo guardavo orgoglioso.
La notte, però, l’ho passata in bianco, per via del campanaccio appeso al collo di Carolina, la mucca più grande, che, quella notte, ha fatto un concerto solo per me. (Inedito da “I racconti dall’Irpinia”, di Giuseppe Tecce)

Sono io
Sono io
L’oggetto dei tuoi desideri
Ciò cui tu aspiri
E che mai sarai.
Io,
Il tenero ed il duro,
Genio maledetto
Per arte ed intelletto.
Sono io
L’eterno insoddisfatto
Cui la vita ha dato
Ed io maltratto.
Sono la mela
Caduta accanto all’albero
Il tarlo che la rode
E la talpa che non vede.
Sono io che
Aspiro ad esser tutto
E tu stai fuori ad osservare
Vedi e non comprendi
Che la vita scorre nelle vene
Il vino è buono ma non conviene.
Sono io
Maldestro e distratto
Incapace in ogni atto
Cui tu aspiri
E che mai sarai .

Benevento città mia
Benevento, città mia.
Rinacqui tre volte
In questo luogo.
La prima fui Diomedes,
quivi approdai
dopo aver usurpato Palladio.
Riservai per questa urbe
un dente
di caledonio.
Qui fondai
il mio regno
anelando perdono
da Afrodite!
Guidai genti
nel ver sacrum
rendendole edotte
nell’uso del cavallo.
Il mio regno
Era da occidente ad oriente
e lo lascia ai Safinei
in cambio di eterna gloria.
La seconda fui Aset,
fui trono,
fui madre
e progenitore
di orde di janare.
Sacerdotessa fasciata di bianco
governai col cenno del capo,
e fiori e fiori
per abbellire la mia
essenza invisibile.
Regina caeli,
madre di tutte le madri
e di tutti i padri,
fui dominatrice
dei due fiumi
che feci unire
al mio cospetto
in unico progetto.
<Tu quidem Sancta
et humani generis
sospitatrix perpetua,
semper fovendis
mortalibus munifica,
dulcem matris

adfectationem miserorum
casibus tribuis>
La terza:
IO SONO.
O Santa e sempiterna salvatrice del genere umano, prodiga dispensatrice di grazie in favore dei mortali, tu offrì il tuo affetto di madre ai poveri che soffrono

Sul treno
Sul treno
Crocevia di colori inconfondibili
Impossibile dire il vero
Sul treno.
Riverberi di luce
Tra sconfinate pianure di silenzio
Tagliate a freddo
Senza respiro
Senza che neppure il prato
Possa gioirsi del suo caldo rantolarsi.
Eppure scorrono eterni
I suoi assi paralleli,
Dritti al mondo
Diretti al cuore.
Un inchino,
un saluto,
occhi che scorrono frettolosi
sulle righe ritorte
di mille spruzzi d’erba.
La rupe si dimena
Si contorce,
si apre,
si chiude
si spezza
muore
nasce
e tutto ancora.
Saluto il mondo di lassù.
Saluto gli alberi vetusti
I giovani arboscelli
Le fresche acque dei torrenti
Le oche starnazzanti
Le rane gracidanti.
Sul treno
Crocevia di colori inconfondibili
Impossibile dire il vero
Sul treno.

L’inoculazione, la caduta ed il volo
Andrea andò a fare il vaccino con meno spensieratezza delle altre volte. Era arrivato alla terza dose, e non sapeva se essere felice per esserne rimasto ancora indenne o essere dispiaciuto per il fatto che si sentisse quasi un tossico alla ricerca spasmodica della prossima dose.
Arrivò al centro vaccinale trafelato, avendo in mente le parole di Genny: lo sai che Adele dopo la terza dose, una volta a casa, è svenuta, cadendo e procurandosi una profonda ferita sulla guancia e sulla fronte.
Andrea mostrò la prenotazione al tipo davanti al cancello, ottenendo un ticket, necessario per mettersi in coda davanti all’ingresso. Attese per 40 interminabili minuti prima che la fila scorresse e si ritrovasse faccia a faccia con l’operatore della protezione civile, che con modi scortesi lo invitò ad entrare e a recarsi presso lo sportello per validare la prenotazione.
Il contrasto tra l’aria esterna, fredda, e l’aria calda interna provocò l’appannamento degli occhiali, e la mascherina FFP2 malmessa fece il resto, peggiorando la situazione.
Che caldo, pensò, mentre era in coda nell’ampio atrio della vecchia caserma, adibita a centro vaccinale.
L’ansia non si teneva più dentro e strabordava in tanti modi : dapprima la gamba destra cominciò a muoversi come impossessata, poi si ritrovò a tamburellare col piede sul pavimento ed infine ad allargare il girocollo, che pareva stringersi attorno alla gola, tirandolo col dito indice della mano destra.
Si guardò intorno. Era circondato da un’umanità varia e sconosciuta. C’era il tizio basso e largo, guance rosse e giubbotto sbottonato, quello di sicuro avrà la pressione alta, pensò. C’era la tipa magra magra, appena ingobbita, con il mento nascosto nel lembo più alto del cappotto di panno pesante, ed abbottonato fino all’ultimo bottone. Il ragazzino, dietro, sbuffava, mentre la distinta signora, di lato, sospirava per l’ansia e per passare il tempo. La fila scorreva lenta e l’omino allo sportello era piuttosto pignolo: voleva la tessera sanitaria ed un documento. Ne leggeva il codice a barre con uno scanner e poi stampava tre fogli che consegnava al paziente di turno, indicandogli, poi, la via da seguire. Quando fu il turno di Andrea, terminata la solita trafila dei documenti, lo instradò verso sinistra. Ecco vede quella coda? Si metta li dietro, ed aspetti il suo turno.
Siamo dei pazienti, disse Andrea sorridendo, ci sarà pur un motivo….
Si spostò in fondo all’ulteriore coda, reclinò il capo. La mascherina affaticava la respirazione, la scostò leggermente dalla bocca per prendere una boccata di ossigeno, fu investito da un fetore misto di azoto e zolfo. Qualcuno aveva scorreggiato, ma l’uso comune delle pesanti mascherine ne aveva attenuato l’effetto sulla popolazione.
Furono altri 20 minuti di attesa. Arrivò il suo turno e fu mandato in una stanza, grande quanto un intero trilocale. Parlò con un medico, seduto dietro ad un banco, di quelli scolastici, piccoli. Firmò un foglio di accettazione del vaccino che stavano per somministrargli e finalmente si mise in coda per accedere alla sala vaccini.
Le sale vaccinali erano divise : sulla sinistra si apriva la sala riservata alle donne e sulla destra quella riservata agli uomini.
Entrarono in cinque e presero posto sulle cinque poltroncine disposte a raggiera nella stanza. Passò l’infermiera, con cinque siringhe già pronte poggiate orizzontalmente in un vassoio metallico. Toccò ad Andrea. Scoprí il bicipite e si lasciò praticare l’iniezione. Fu indolore e priva di sensazioni.
Fu accompagnato nella sala di attesa post vaccino, dove, dopo ulteriori 15 minuti, gli fu consegnata l’attestazione di avvenuta somministrazione e fu libero di andar via.
Uscì dalla porta laterale, abbassò la mascherina e finalmente poté respirare ossigeno, fresco ed inodore.
Il pensiero di Adele, del suo malore, e le parole gravide di pathos di Genny, si insinuarono ben presto nella sua testa. Quando arrivò allo sportello della macchina ebbe una vertigine, la vista gli si annebbiò, gli tremò la mano.

Tornò a casa guidando in maniera distratta, a tratti pensò di non ricordare più nemmeno la strada.
Parcheggiò la 500 X amaranto proprio sotto casa e corse nel suo appartamento.
Bevve con ingordigia un’intera tazza di acqua. Era solito usare le tazze in luogo dei bicchieri, perché più capienti. Si toccò il punto esatto del braccio in cui era stato iniettato il farmaco e non sentí dolore.
Strano, pensò, nelle due precedenti somministrazioni il braccio era stata la prima parte del corpo a dolermi, ed ora mi dolgo per il mancato dolore.
Riguardò con attenzione il selfie che aveva scattato al momento del vaccino. Era indubbio: l’ago era stato infilato nella carne. L’idea che l’infermiera avesse fatto una finta iniezione era da scartare completamente.
Si sedette sul divano. Il televisore trasmetteva immagini colorate, senza l’audio, che era stato eliminato. Passarono due ore, si trascinò in cucina per prepararsi il pranzo.
Terminò in fretta. Non avvertiva né il dolore al braccio, né sintomi di altro tipo. È impossibile, pensò, Adele è svenuta dopo il vaccino. Devo restare vigile ed in attenzione, che da un momento all’altro toccherà anche a me.
Passò ancora un’ora, ma nulla di strano accadde. Accese un fornello, poi lo spense, pensando fosse pericoloso. In caso di mancamento, non solo si sarebbe spaccato il volto, ma avrebbe rischiato finanche di bruciarsi.
Si spostò, quindi, in camera da letto. Avvertì un lieve dolore al piede sinistro ed un accenno di zoppia. Prese la stampella che aveva riposto nell’armadio tempo addietro, ed utilizzata per via di una caduta.
Camminò con quella all’interno della casa per abituarsi. Simulò più volte una caduta, ma, di fatto, la caduta non arrivò , e nessun mancamento gli si presentò.
Le parole di Genny gli rimbombavano nella testa: se Genny aveva pronunciato quelle parole, non poteva essere altrimenti. Prima o poi, come è accaduto ad Adele, io mi ritroverò in terra, spaccandomi lo zigomo o forse la fronte.
Pensò che la cosa più saggia sarebbe stata quella di riempire il pavimento di cuscini e di altro materiale morbido, che avrebbe potuto attenuare la caduta, in caso di necessità. Così fece, cospargendo l’ampio pavimento di guanciali e cuscini da divano. La casa divenne un tappeto colorato e soffice, che avrebbe potuto fare la felicità di qualsiasi bambino.
Si sedette poi sull’ampio divano, restando in ascolto del proprio corpo, delle proprie emozioni, delle proprie sensazioni. Rimase così per tre ore, nel silenzio, pensando a Genny e ad Adele.
Poi dalla schiena gli spuntarono due ali e, senza saperne il perché, volò via.

Giovanni e la bocca sana
Giovanni, 46 anni, operaio edile in attività. Busta paga di circa 1200 euro mensili, tre figli, una moglie a carico, ed una casa di proprietà, frutto di un’eredità maturata qualche anno prima, con la morte del padre, e per la quale aveva dovuto pagare un’esosa tassa di successione.
La mattina del 15 Aprile, durante la pausa pranzo, sul cantiere, addenta un croccante marsigliese farcito con della profumata mortadella. Un dolore sordo, seguito da un crack, nella parte laterale della bocca, gli promuove una lacrima. Continua a masticare, il dolore aumenta, e si accorge di avere un corpo estraneo in bocca. Sputa in un fazzoletto, e vede un frammento piuttosto grosso di un molare e da quel momento comincia la sua odissea nella sanità pubblica.
Giovanni, fino a quel momento non aveva mai avuto grossi problemi di salute e si era curato sempre con una sorta di fai da te con il supporto del medico di base. Ma l’esperienza che stava per iniziare avrebbe cambiato per sempre il suo rapporto con il mondo della sanità. Il dolore al molare rotto aumenta con il passare dei giorni, la gengiva si gonfia e si rende necessario fare una visita dal medico di base: dottore ho, presumibilmente, un ascesso ad un molare. Ho bisogno di una visita odontoiatrica e vorrei farla in ospedale. Il dottore lo ascolta, gli guarda la bocca e sentenzia: sei certo di voler andare in ospedale? Non credo che ti cureranno il dente, al massimo ti proporranno un’estrazione. Dottore, suvvia, disse Giovanni sorridendo, se necessario me lo cureranno. Perché eliminare un dente, se ancora si può fare un lavoro di recupero? Il dottore alzò le spalle ed eseguì quanto gli era stato richiesto, scrivendo al pc una ricetta per visita odontoiatrica.
La mattina stessa, Giovanni chiama il CUP del locale ospedale civile, chiedendo una prestazione odontoiatrica, forte del fatto di essere in possesso di una regolare prescrizione medica. La donna dall’altra parte del telefono, dopo una breve pausa di riflessione, sentenzia: la visita con la ricetta la possiamo fissare per il 5 Maggio. Ma di questo anno? scherza Giovanni, ignaro dei gangli della sanità pubblica. Si, signore il 5 Maggio di quest’anno, rispose la donna. Ma, signora, io ho un ascesso dentario, e non posso aspettare per un tempo così lungo. Signore, proruppe la donna con tono scocciato, la sua ricetta non ha la caratteristica dell’urgenza. Se ha bisogno di una visita urgente chiami il suo medico e si faccia sostituire la ricetta. Giovanni riaggancia meravigliato e ritorna dal proprio medico di base, fa di nuovo la coda in sala di attesa e al momento in cui si ritrova faccia a faccia con il dottore gli chiede spiegazioni del perché non gli abbia fatto una richiesta di visita urgente. Il medico si scusa in qualche modo, annulla la ricetta emessa, e ne scrive una nuova con la dicitura di urgenza. Giovanni, che intanto ha già perso una giornata di lavoro, esce dallo studio, e considerata l’ora non può più chiamare il CUP. Lo avrebbe fatto l’indomani mattina. Con la ricetta alla mano, telefona e parla, questa volta con un uomo. Salve, sono Giovanni, ho bisogno di una visita odontoiatrica d’urgenza. Certo signore mi fornisca il numero della ricetta , scritto in alto a destra sotto al codice a barre: inizia per 1500 A. Giovanni cerca il numero e glielo detta. L’uomo risponde: bene, vedo che ha una richiesta di urgenza, pertanto potrà venire a fare la visita Giovedì pomeriggio alle 15. Si presenti al CUP alle 14, paghi il ticket, e poi sarà libero di recarsi in ambulatorio. Ma oggi è Martedì, dice Giovanni alzando il tono della voce, e dovrò aspettare ancora due giorni per essere visitato? Il molare mi duole. Mi dispiace signore, il primo posto disponibile è per giovedì alle ore 15. Le confermo la prenotazione? Va bene, risponde Giovanni, con un moto di rassegnazione. Giovedi alle 14 Giovanni si presenta al CUP. Ha dovuto lavorare mezza giornata. Alle 14.30 paga il ticket e si reca presso l’ambulatorio odontoiatrico. Il dottore è in ritardo e tutte le visite saranno spostate in avanti di un’ora. Alle 16 finalmente entra nella sala medica. Si siede sulla poltrona e dopo aver spiegato al medico l’accaduto, apre la bocca per farsi visitare. Il dottore esplora il cavo orale con lo specchietto, ed effettivamente, trova l’ascesso. Tocca il dente, lo guarda, poi chiede a Giovanni di alzarsi. Si spostano verso la scrivania, dove il dottore, incrociate le dita delle mani, con i gomiti appoggiati sulla scrivania, dice: Senta Signor Giovanni, il suo dente non è in condizioni tali da dover essere estratto. Si può curare e con una capsula avrà un dente come nuovo. Bene, esclama Giovanni, quando possiamo cominciare la cura? Forse non mi sono espresso bene, continua il dottore, con aria incupita: noi non possiamo curarle il dente e men che meno possiamo incapsularlo. E’ un tipo di lavoro che possiamo eseguire in rari casi, previsti espressamente dalla legge, per persone che si trovino in una grave condizione di vulnerabilità sanitaria o sociale, e credo che lei non rientri in nessuna delle due categorie, pertanto le prescrivo un antibiotico per ridurre l’ascesso, ed un antidolorifico per ridurre il dolore. Poi le consiglio di rivolgersi ad uno studio odontoiatrico privato che pratica la chirurgia conservativa del dente. Giovanni, lo guarda con meraviglia e si ricorda delle parole del medico di base. Si alza e saluta il dottore con gentilezza, ma con il cuore in frantumi per la delusione. Giovanni ha perso all’incirca due giornate di lavoro, i soldi del ticket per la visita presso l’azienda ospedaliera locale, ed uscito dall’ospedale chiama il medico dentista il cui numero gli è stato fornito dal cognato. L’appuntamento è per la sera stessa alle 19, per iniziare il percorso medico che lo porterà ad avere, di nuovo, una bocca sana, ed un portafogli molto più leggero. (Dicembre 2022)

Nelle pieghe silenziose
Nelle pieghe silenziose dell’Alta Irpinia,
si nascondono case, sospiri di pietra.
Sfumature di grigio e di memoria,
intrecciano i giorni in un abbraccio di nebbia.
Qui, dove il tempo sembra fermarsi,
ogni angolo sussurra di storie non dette,
e i passi riecheggiano, echi di un tempo altro,
in un paesaggio che abbraccia il cielo.
La nebbia, timida danzatrice,
si avvicina e si allontana in un dolce gioco, celando e svelando i segreti del villaggio,
dove ogni cuore batte al ritmo della terra.
In queste case, dove il silenzio parla,
ogni finestra guarda al domani,
mentre l’anima del paese,
sogna sotto il velo di un tramonto senza fine.

Sopra i tetti
Sopra i tetti, il cielo si tinge di un grigio plumbeo, che riflette i pensieri dei suoi abitanti.
Un filo di storie appese, i panni che raccontano la vita quotidiana con i loro colori vivaci.
E là, una parabola che ascolta i segreti del vento, i sospiri delle colline, la voce lontana delle stagioni che cambiano.
Questo è il teatro delle piccole esistenze, dove ogni finestra custodisce un racconto, ogni antenna cattura sogni, e ogni molletta lascia il segno, delicato, sull’epidermide del tempo.
